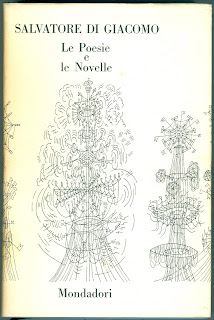Nel raccontare l’inaugurazione avvenuta il 4 novembre 1737 del Teatro San Carlo a Napoli, Salvatore Di Giacomo riproduce integralmente una lunga lettera che la signora Isabella, principessa di Caposele, ancora eccitata dalla serata trascorsa, scrive alla sua amica donna Violante Zanolin a Venezia.
Da questa lunghissima lettera, scritta probabilmente con i primi pennini in oro o in argento che già si producevano nel XVI secolo, esce il ritratto di una donna orgogliosa della sua posizione sociale, che non si lamenta troppo dei tradimenti del marito, abbastanza vanitosa da descrivere con compiacimento l'elegante vestito indossato e gli accessori ricercati comprati a Parigi, oppure le attenzioni che la sua bellezza ha suscitato in alcuni giovani ammiratori. La lettera ci mostra anche una società dove persino i comportamenti erano rigidamente regolati dal sovrano, che ne stabiliva le regole, con pene severe per i trasgressori.
Per quante ricerca abbia fatto sul web, non sono riuscito a sapere alcunché di questa Isabella, principessa di Caposele, né a trovare un suo ritratto, che sicuramente qualcuno dei grandi pittori napoletani dell'epoca avrà dipinto. E, tutto sommato, questa è una buona notizia perché significa che per fare vere ricerche storiche bisogna sporcarsi le mani, rovistare tra vecchi e polverosi libri e in-folio, giacenti in biblioteche poco frequentate, negli archivi di parrocchie e conventi o di antiche istituzioni araldiche, o nei musei, perché con un click del mouse si accede solo a una paccottiglia che si ripete all'infinito.
Ed ecco la gradevolissima lettera di Isabella:
Di casa, li 4 novembre 1737
Amabilissima mia Violante,
La costanza della tua amicizia è sprone continuo
al mio affetto e in tale maniera da farmi del continuo aver presente la
immagine tua, così nelle occasioni liete come pure nelle tristi. Sia qualunque
il piacere o il dispiacere che l’anima mi tocchi, io sempre a te rivolgo il
pensiero, e in quello io dico: Se presente l’avessi come con me godarebbe la
mia Violante! E, in questo, sospiro: Se meco fosse l’amica mia come il dolore mi
renderebbe men grave!
Sono le due ore della notte. Ritorno dal teatro di
San Carlo, questa sera per la prima volta aperto alla maraviglia dei Napoletani
e con musica e ballo inaugurato alla invitta presenza di Sua Maestà, Dio
guardi.
Il mio signor marito, principe di Caposele, che in
questo momento si è menato nel letto e dorme, essendo stanco per lo continuo
giro per li palchi di visita, possedeva, come tu ben sai, un palchetto al
dismesso teatro di S. Bartolomeo, in dove pagavamo di appalto solo ducati
novanta. Lo stesso palco di seconda fila ci viene ora al S. Carlo ducati
settecento ma volentieri li vuol pagare mio marito per avere il piacere di
godere della vicinanza della M .S. ed ossequiarla. Anzi, non ostante la
mutazione dell’aria e il continuo piovere, mio marito si è portato lo scorso
giovedì dall’ Uditore dell’ Esercito a fissare il palchetto.
Che spettacolo, Violante carissima! Della musica
non ti parlo essendo che tu ben sai che io poco ne capisco di questa musica
seria; mio marito dice che è stata lodatissima e diffatti il pubblico con
continui battimenti di mani le ha mostrato il suo gradimento. Ma io – giacché
siamo a quattr’occhi – ti dico che ci provo maggior piacere quando Scarlatti se
ne viene a suonare un allegro o un
minuetto al clavicembalo di casa nostra. Che dir ti posso? Sarro potrà essere
un maestro di cappella rispettabilissimo, ma pel teatro, secondo il mio debole
parere, è troppo lamentoso. Sua Maestà, Dio guardi, se l’ha fatta a dormire
quasi tutta la serata. Insomma musica seria, bella mia, ma seria assai e non
fatta per li nostri orecchi.
Mi sono alquanto dispiaciuta nell’udire da mio
marito, informatosene dall’ Uditore, che non si potesse da noi piazzare Impresa
alcuna di casa nostra al palchetto fittato. Il Re, Dio guardi, ha ordinato che
niuno dei proprietari possa fare scolpire o dipingere nemmeno in cifre le Armi
del suo casato nel palco, o altro contrassegno che dinoti Impresa dello stemma
gentilizio della famiglia. Mi ha fatto
sommo piacere, al riscontro, l’ordine pure di S. M. emanato che non si dovesse
fumare nelli corridoi, per evitare lo sconvolgimento di stomaco delle Dame. Per
simile dannoso incomodo il dismesso teatro S. Bartolomeo era diventato una
caserma e tu sai come soffro in simili contingenze che poco onorano la nobiltà.
Violante mia, che lumiere, che sfarzo, che colpo
d’occhio! Il Re è arrivato in punto all’ora fissata per il principio dello
spettacolo e subito la conversazione ch’era nelli palchetti e platea si è
interrotta. Il primo cembalo ha attaccato il real pezzo seu l’inno e sono
scoppiati immensi battiti di mani con grida di: viva il Re! Viva la Regina! Con
levarsi tutti all’impiedi e con riverenze. S.M. la Regina, Dio guardi, stava un
prodigio e sembrava, in lontananza, bella al maggior segno, abbenché mi si dice
da chi ha potuto avere la fortuna di avvicinarla che sia alquanto rovinata dal
vaiuolo in faccia. Il suo pellucchiero non è dei più famosi né S.M. troppo
s’intrattiene alla tualetta, per essere piuttosto di modesti e religiosi
costumi: la sua tualetta è l’oratorio, la sua acqua di odori è l’acqua santa.
Benedetta! Così potessi fare anch’io, preparandomi il posto in paradiso. Ma il
mio confessore, don Pietro Vigorito a S. Giacomo, mi ha detto che la tualetta
si può fare quando è fatta senza iscandalo e con nobile tranquillità. Se vuoi sapere come mi sono accomodata con
l’aiuto ingegnosissimo dell’abate Zanetti, che tu avesti a conoscere l’anno
scorso e che vive di me prigione, eccoti soddisfatta.
Pettinatura all’ Amadigi, abbenché poco mi garbi.
Però il pellucchiero dice che li ricci contornano amabilmente l’ovale del mio
volto, e bisogna sentire il pellucchiero. Le moschette si portano in quantità ma non mi sono adattata se non che
una passionata, due galanti, e una assassina all’angolo delle labbra. Nei capegli ho messo alcune
perle delle stesse di cui mi stava un filo doppio al collo nudo. Anche il
corsetto tortorella, molto lungo e appuntato come si porta, era filettato in
lungo da perle e così le aperture delle maniche a sbuffi, allo margini. Tutta
la guarnizione, con alcuni altri complimenti, è amabil dono di mio marito che
l’ha comperata a Parigi. La veste è quella che tu ben conosci, di seta di color
di rosa e tulipani a rilievo. Ne ho
fatto mutare i falbalà e ci ho messo frangia di merli d’argento che fanno più
figura. Alli sgonfii laterali una guarnizioni di nocchette naccarà, che ci
stanno un amore. Ventaglio con pitture di un certo Fragonard di Parigi, anche
dono di mio marito. Mi dicono che è meraviglioso. Io tutta questa meraviglia
non ce la trovo: due puttini, un cane e un poco d’erba, questo è tutto. Invece
la montatura d’avorio è ricca assai; le bacchette sono traforate e con il
traforo formano il mio nome.
Forse mi sono scollata un po’ troppo: il
principino di Tarsia, che stava nel palchetto accanto al nostro, se l’ha fatta
a sbirciarmi tutta la santa serata. Peggio per lui. All’uscita mi ha servito il
braccio quel giovine viniziano ospite del duca di Telese, nostro vicino di
casa. Giovine alquanto pericoloso. Mi andava dicendo per li corridoi che io
odoravo “tre mia lontan”, ch’era stata tra le più belle della festa, che
meritava un trono. E ogni volta soggiungeva sottovoce: - Mi perdarò la salute,
siora Isabella!
Vengo all’opera in musica. La Tesi è stata un
portento nella parte di Achille che è uscito vestito da donna, come prescrive
il libretto. Ma la Peruzzi mi è piaciuta più assai; è piccola di statura,
acconcia ed ha un timbro di voce squisito. La Tesi mi pareva il gigante di
Palazzo. Il tenore Amorevoli è stato sorpassato dal secondo uomo Marianino che
si attraeva l’universale applauso. Scene stupende del Richini di Torino e
ballarini dei migliori, che molto hanno
dilettato S. .M. fino all’ultimo padedù. Al grido finale del coro, nel Prologo
in dove apparivano la Magnificenza, la Gloria e la Celerità, tutti levatisi in
piedi hanno gridato: Viva Carlo ! E il re con ripetuti abbassamenti del capo ha
mostrato il suo Real gradimento.
Mi è piaciuto leggere un Reale dispaccio appeso in
corridoio, che non sia permesso di salire sulla scena né prima né dopo la
recita sotto pena di due anni di arresto in Castelnuovo per i nobili. Caposele
mio marito non ripeterà le sue prodezze di San Bartolomeo. Se tu sapessi che mi
ha fatto passare per la cantarina Rosa Albertini che poi fu uccisa, poveretta!
Nemmeno si può applaudire senza che il Re o la Regina non ne diano il segno, né
far replicare qualche aria che incontri piacere, e ciò per non fare campeggiare
alcune poco decenti protezioni le quali hanno bastantissimo motivo di
mormorare.
Tu mi dirai: - Come è stato in così poco tempo
fabbricato un immenso teatro? – Che dir ti posso? La mia mente ancora stordita
dallo spettacolo mi par come immersa in un sogno. Tornando a Napoli vedrai, la
mia dolcissima Violante, cosa che non ha al mondo intero la somiglianza, per
lusso, per ricchezza, per vastità. Più che mai ti desidero vicina in questo
riscontro, onde ammirar tu possa ben presto lo sfarzo di Napoli, delle dame e
cavalieri in così nobil luogo raccolti.
Termino con abbracciarti ripetutamente, pregandoti
se non ti è grave incomodo, di farmi avere il quaresimale del padre Sampieri,
che mi dicono dottissimo, e due paccotti della tua cipria al bergamotto con un
paio di guanti fini e lo “zendaletto” viniziano che mi promettesti. Scusami,
perdonami, Violante carissima, ma la tua bontà mi spinge: Benedetta el pare che t’ha fata! Con mille e mille baci. Tua
Sabella Caposele

.JPG)